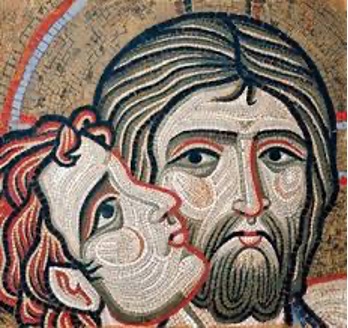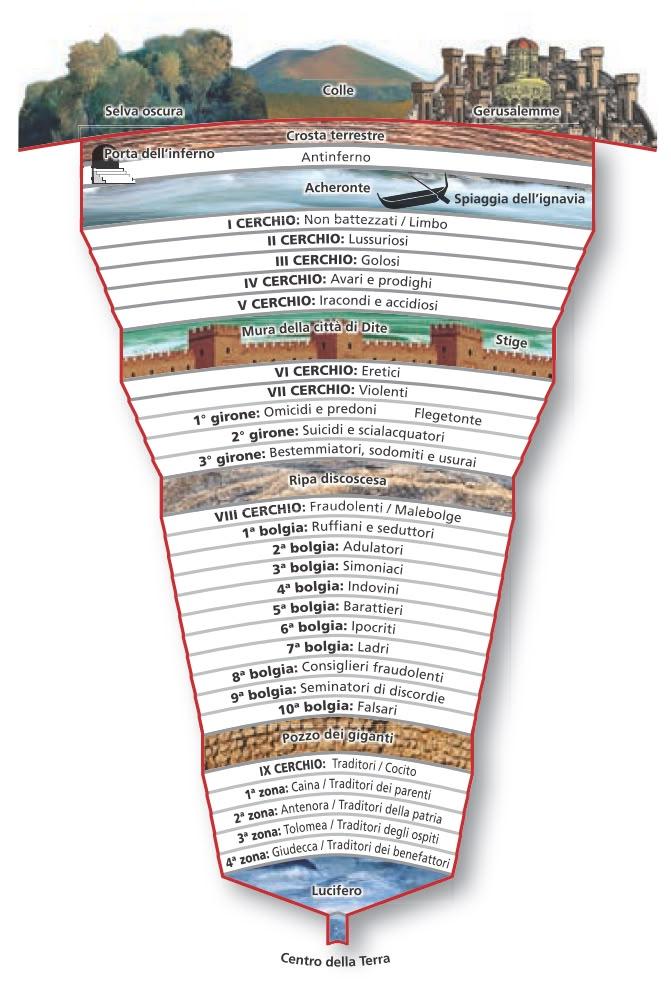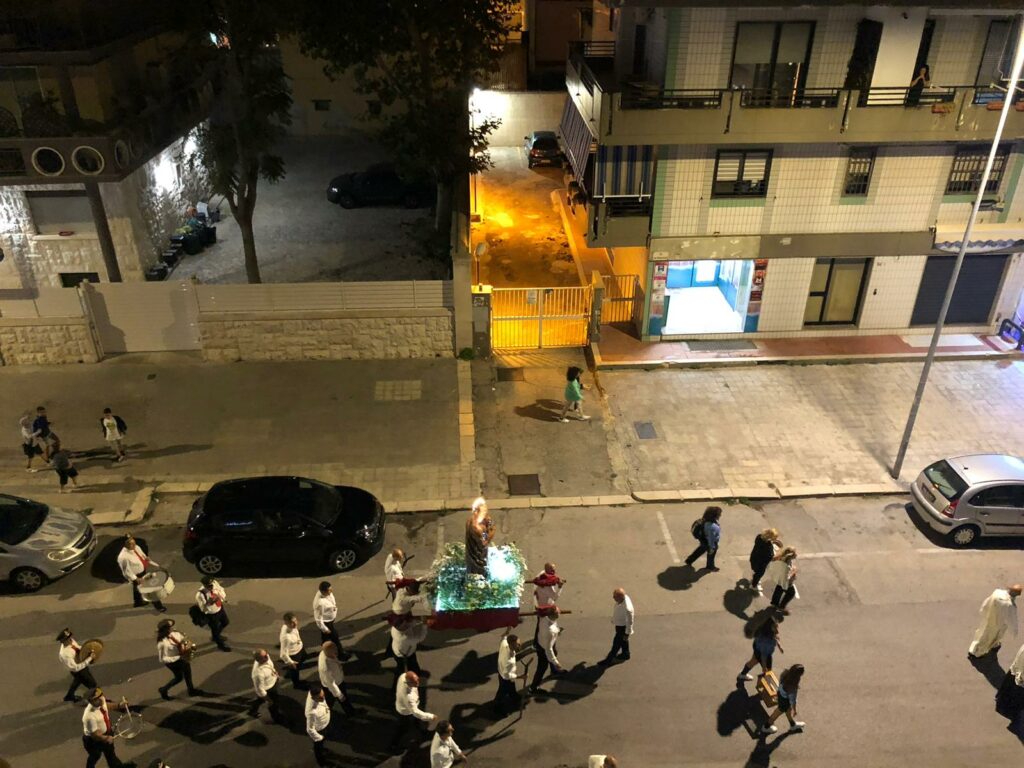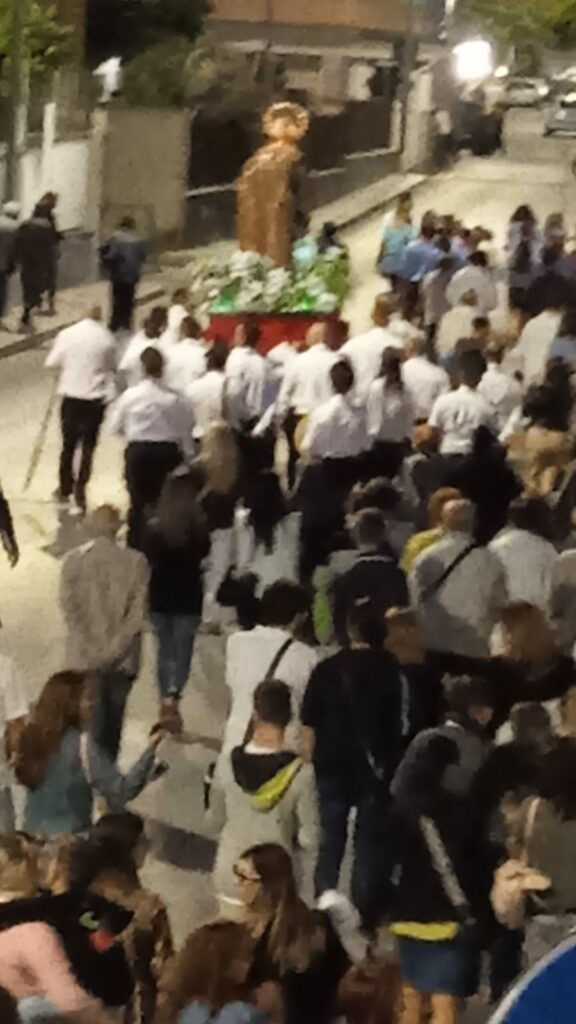Un popolo in cammino
Come i discepoli di
Emmaus
Giorno
dell’istituzione dell’Eucarestia
“
dell’agonia
“
del tradimento di Giuda
“ del tradimento/rinnegamento di Pietro
“
della Lavanda dei Piedi, dell’umile chinarsi del Cristo sui piedi dei
discepoli come lezione valida per tutti i tempi e per tutti i luoghi.
Quest’anno,
a livello di calendario, celebriamo la c.d. “Pasqua bassa”, infatti tra qualche
giorno daremo il “benvenuto” al mese di aprile.
Un
antico detto recita: Aprile dolce dormire…
In realtà questo detto si coniuga a un altro molto famoso,
che sin da bambini abbiamo sentito dai nostri genitori: “Chi dorme non piglia
pesci”.
Innanzitutto,
questo antico detto italiano sta a significare che non si ottiene nulla senza fatica e che, senza darsi da fare, non si
realizza nulla di buono. Il detto, non a caso, prende esempio dall’attività
del pescatore la cui particolarità è quella di non lasciarsi sfuggire il pesce
nel momento in cui abbocca. In questo modo, chi si trova davanti alla canna da
pesca deve rimanere sempre concentrato per non rischiare di perdere l’attimo
in cui il pesce afferra l’esca. Chi
dorme non piglia pesci, quindi, si riferisce a chi riposa troppo anziché
impegnarsi nel proprio lavoro e rimanere all’erta e invita a dedicarsi con
dedizione ai propri obiettivi per perseguire i propri scopi.
D’altra
parte non si nega il dato incontrovertibile che senza un riposo adeguato, il
conseguimento dei propri obiettivi sarebbe praticamente impossibile.
Si
potrebbe dire che dormire sia una cosa “ovvia”, naturale per ogni uomo, eppure,
come tutte le cose più ovvie ma originarie e fondanti la nostra umanità,
presuppone molto di più di quel che sembra.
Esiste
un sonno buono, profondamente umano. «Non mi piace chi non dorme, dice Dio»,
canta Charles Péguy, che definisce il sonno «l’amico di Dio» e fa dire al
Creatore: «Il sonno è forse la mia più bella creatura». Esiste una sapienza che
deriva soltanto dall’abbandonarsi come bambini nelle braccia paterne di Dio. Ma
io non sono più un bambino! — protesta il vecchio che ognuno di noi porta
dentro di sé. Sicuramente Dio non ci vuole incoscienti o immaturi, ma neppure
possiamo sentirci addosso la responsabilità della salvezza della Chiesa e del
mondo. L’opera di Dio si realizza con ritmi e tempi che non sono sotto il
controllo di ognuno di noi: «Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme
germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa» (Mc 4, 27).
Il
sonno, infatti, è fondamentale per ricaricarsi e per recuperare al meglio le
forze per affrontare una nuova giornata. Rigenerare le cellule del proprio
corpo, in particolare quelle del sistema nervoso, è un’attività che il sonno
porta con sé e che rimane fondamentale per il nostro organismo. Chi dorme quindi non piglia pesci? Forse
è solo questione di quante ore si dedica al riposo!
La Chiesa non può dormire, è chiamata a
riflettere, discernere e prendere poi posizione, non può tacere la verità,
perché verrebbe meno alla fedeltà verso Dio Creatore e non aiuterebbe a
discernere ciò che è bene da ciò che è male (Giov. P.II Angelus 9.7.2000).
“Sono
venuto a portare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso!” (Lc
12,49)… “Questo è il fuoco dello Spirito Santo. Se la Chiesa non riceve questo
fuoco o non lo lascia entrare in sé, diviene una Chiesa fredda o soltanto
tiepida, incapace di dare vita, perché è fatta da cristiani freddi e tiepidi.
Ci farà bene, oggi, prendere cinque minuti e domandarci: “Ma come va il mio
cuore? È freddo? È tiepido? È capace di ricevere questo fuoco?” Prendiamoci
cinque minuti per questo. Ci farà bene a tutti. E chiediamo alla Vergine Maria
di pregare con noi e per noi il Padre celeste, affinché effonda su tutti i
credenti lo Spirito Santo, fuoco divino che riscalda i cuori e ci aiuta ad
essere solidali con le gioie e le sofferenze dei nostri fratelli” (PAPA
FRANCESCO, ANGELUS Domenica, 14 agosto 2016).
Su una rivista mi è capitato di leggere la risposta a una critica
di inerzia alla Chiesa da parte di un giovane sacerdote:
La Chiesa e la corrente
Caro
Beppe, pur in una serie di osservazioni che in parte condivido, penso che tu
abbia sbagliato biasimando gli ecclesiastici per la mancanza di attenzione e
proposta di vita per le ragazze e i ragazzi che abitano le nostre città e le
nostre case.
E’ sbagliato perché la
Chiesa è forse l’unica istituzione che rema controcorrente su molti piani:
prima di tutto cercando di stare con i ragazzi. Io sono sacerdote non perché
fulminato sulla via di Damasco da qualche intuizione dottrinale, ma perché ho
trovato gente (laici, preti, suore) che mi ha fatto compagnia, e il loro modo
di farlo era da cristiani.
Quindi ho trovato il Cristianesimo interessante (e intelligente).
Quante altre “agenzie” davvero stanno con i nostri ragazzi? E poi
come ci stanno? Quanti di voi, anche genitori, hanno davvero provato a mettere
in questione, per esempio, la visione di una sessualità consumista, o che cosa
vuol dire avere degli amici? Quanti hanno avuto il coraggio di parlare del
senso e della profonda, temibile bellezza di volere il bene dell’altro come e
più del proprio (forse perché alla fine il mio e il tuo bene coincidono, ma
alla fine…)?
La
chiesa convocata da Gesù è una Chiesa che inizia ad essere tale camminando con
Gesù per le strade polverose della Galilea, della Samaria, della Giudea… del mondo
intero.
La
Chiesa non è formata da battitori liberi o da élite ma dall’insieme di coloro
che hanno creduto e continuano a credere nel Signore morto e risorto, vivono
nella sua parola e dei segni sacramentali della salvezza.
Camminare
insieme richiede di saper incontrare, ascoltare, saper condividere.
La
Chiesa, nei piani di Dio, è popolo in cammino, un popolo che cerca nel Signore
la propria guida e che ritrova nel Pane eucaristico la forza per il proprio
cammino verso il Regno di Dio.
1. In realtà, tu, o Signore,
sei
sempre con noi.
Con
divina discrezione,
spesso
non riconosciuto,
tu
in persona ti accosti a ciascuno di noi
e
cammini con noi.
Tu
continui, instancabile, a camminare con noi,
ogni
giorno e nelle più diverse circostanze,
anche
quando siamo smarriti e confusi,
quando
la fede vacilla
e
la speranza viene meno,
quando
la vita conosce la prova e la sofferenza
o
viene attraversata dal dramma e dalla disperazione,
quando
nelle famiglie
viene
turbato e minacciato l’amore
si
insinua il tarlo della divisione
e
irrompe il fallimento.
Tu
cammini anche per le nostre strade
Dove
la fede rischia di essere oscurata
dall’indifferenza
e dall’affanno,
dalla
chiusura e dall’egoismo,
dal
rifiuto dei valori
che
nel tuo Vangelo trovano la loro linfa vitale.
Anche
qui tu sei presente e vivo
come
il Viandante misterioso,
che
non si impone ma si propone
e
che, con paziente amicizia,
si
fa partecipe di tutte le vicende del mondo,
per
ridare a tutti
luce
e conforto, speranza, gioia e pace.
2. Sì, o Signore,
tu
cammini con noi.
E
nel cuore di ciascuno,
come
in quello dei viandanti di Emmaus,
fai
risuonare la tua parola
che
tutto definisce, tutto spiega, tutto redime:
una
parola che aiuta a scoprire
e
che promuove ogni germe di bene e di amore,
che
denuncia e giudica,
che
annuncia giustizia e offre perdono,
che
tutti interpella, libera, consola e salva.
Questa
stessa parola
tu
hai affidato alla tua Chiesa,
perché sia madre e maestra per tutti i
suoi figli
e
all’umanità assetata di felicità e bisognosa di Dio
indichi
la strada sicura
che
conduce ogni uomo al porto sospirato dell’incontro con te,
unico
e universale Salvatore del mondo:
con
te, che nulla togli alla libertà e dignità dell’uomo,
che
non impoverisci la nostra esistenza
ma
la rendi più vera, più ricca, più bella e più grande,
perché
a noi doni te stesso,
che
sei nostra via, verità e vita,
nostro
bene sommo e incomparabile tesoro.
Fa’,
o Signore,
che
continuiamo ad affidarci alla tua parola
e
a fidarci di te,
per
dare senso autentico e pieno
alla
nostra vita e a quella del mondo
e
così prendere il largo nel mare della storia,
per
gettare le reti e conquistare gli uomini al Vangelo.
3. Animati da questa parola
che
illumina e riscalda il cuore,
anche
noi, come i discepoli di Emmaus,
ti
invochiamo con tutta la forza della nostra debole fede:
“Resta
con noi, Signore!”.
Fermati
e non passare oltre,
entra
nelle nostre case di viandanti senza meta.
Resta
con noi:
non
lasciarci prigionieri delle ombre della sera,
sostienici
nella stanchezza,
perdona
i nostri peccati,
orienta
i nostri passi sulla via del bene,
donaci
di gustare la grazia e la gioia della tua amicizia
che
non delude e non abbandona mai.
Resta
con noi, Signore,
perché
senza di te non possiamo vivere:
per
tutti tu sei l’assolutamente necessario!
Resta
con noi, Signore,
perché
tu, il risorto e il vivente,
sei
«tra noi la speranza della gloria» (Colossesi 1, 27)
già
in questa vita e oltre la morte.
Resta
con noi, Signore,
perché
tu sei la grande, la vera,
l’unica
“ricchezza” della Chiesa e dell’umanità.
4. Resta con noi, o Signore,
e
spezza ancora il pane per noi.
Ripeti
tra noi
il
gesto straordinario dell’ultima cena,
che hai ripreso con i discepoli di
Emmaus la sera di Pasqua.
Confermalo
con le tue parole di vita eterna
e
continua a donarci il tuo Corpo e il tuo Sangue,
vero
cibo e vera bevanda
per
la vita del mondo.
È
qui, nell’Eucaristia,
sorgente
e vertice di tutta la vita cristiana,
cuore
pulsante della nostra fede,
che
noi ti riconosciamo, o Signore,
come
presenza, dono e mistero
che
edifica la Chiesa,
che
ci accoglie come discepoli,
ci
rende tuoi commensali,
ci
fa, come te, servi per amore.
Noi
ti adoriamo, o Dio,
che
nel pane e nel vino eucaristici
a
noi ti doni.
Ti
doni e ti nascondi.
Ma
anche se ti sottrai alla nostra vista,
mentre
siamo seduti a tavola con te,
i
nostri occhi si aprono e riconoscono il tuo volto
e
il nostro cuore ti grida: “nostro Signore e nostro Dio”.
Siamo
affascinati e conquistati,
come
da vera beatitudine,
dall’invito
alla tua cena.
Riacquistiamo
la speranza perduta
e
siamo colmati di una gioia immensa
che
non possiamo trattenere per noi.
5. Ed ora, o Signore,
da
questo fortunato incontro eucaristico
anche
noi, come i discepoli di Emmaus,
partiamo
senza indugio,
torniamo alle nostre case e alle nostre
occupazioni,
corriamo
sulle strade del mondo in cammino verso Gerusalemme,
la
città di Dio e dell’uomo,
dove
il frutto dell’incontro con te nella parola e nel pane
diventa
vita di amore fraterno e universale.
In
comunione con tutta la Chiesa,
anche
noi ci riconosciamo “mandati”
ad
annunciare a tutti la bella e lieta notizia
del
tuo amore per gli uomini
e
a farci appassionati e instancabili promotori
di
comunione, di solidarietà e di pace,
così
da costruire una società più equa e fraterna.
Rinvigoriti
dalla forza del cibo eucaristico
e
animati dal fuoco della missione
che
lo Spirito accende in ciascuno di noi,
riprendiamo
il nostro cammino
di
pellegrini nella storia e per le strade del mondo,
quali
missionari di Gesù e del suo Regno,
per
rivolgere a tutti l’invito
a
partecipare alla mensa del Signore,
promessa
e garanzia di una vita vera
e
di una festa che non avrà mai fine.
Resta
con noi, Signore,
resta
con noi,
ora
e sempre.
Amen. (+ Dionigi card. Tettamanzi)
Per questo la Chiesa veglia e non dorme nella notte di Pasqua: essa lì sperimenta e testimonia che il sonno di morte non c’è più, perché Gesù, nostra vita, per noi l’ha cambiato per sempre in un sonno dal quale ci si risveglia, dal quale si risorge.
don Pasquale